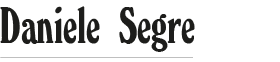Paolo D’Agostini/La Repubblica
La figura di Daniele Segre — piemontese, sessantenne, fortemente legato alle proprie radici ebraiche, fama di scontroso e sulla breccia da metà anni 70 con oltre settanta titoli realizzati, con le carte in regola per esibire il profilo ideale del filmaker indipendente — è anomala e di questa anomalia ha fatto la sua piuttosto compiaciuta veste di David contro Golia. Anomalo perché quasi mai racconta storie di finzione ma considera anche riduttiva la qualifica di documentarista. Fa “cinema della realtà” o tutt’al più “di documentazione sociale”. Correndo laddove ci sono emergenze, immergendosi spesso in situazioni dolorose. Sempre, o quasi, a partire dalle proprie forze produttive: la piccola società I Cammelli che ha una trentina d’anni..
È da pochi giorni in libreria per Feltrinelli un cofanetto che (accompagnato da un piccolo ma prezioso libro) raccoglie quattro film dedicati al tema del lavoro. Sotto il titolo complessivo Vivere e morire di lavoro troviamo: Dinamite (1994) e Asuba de su serbatoiu (2000/2001) realizzati in Sardegna rispettivamente tra i minatori della Carbonsulcis e tra gli operai della Nuova Scaini di Villacidro resistenti alla smobilitazione e alla prospettiva di licenziamento, Morire di lavoro (2008) toccante raccolta di testimonianze su chi ha pagato con la vita l’assenza di misure di sicurezza soprattutto nell’edilizia, e infine Sic Fiat Italia (2011) sul referendum sottoposto da Marchionne alle maestranze di Mirafiori che si concluse con un 54% a favore del “sì”. Spiega il regista: «Abbiamo valutato che questi quattro titoli (peraltro contenenti rimandi e citazioni di altri lavori come Partitura per voci e volti e Un solo grido lavoro) fossero abbastanza significativi di un percorso. Quello mio attraverso il processo di esproprio graduale dei diritti del lavoratori». Ma figuriamoci se a Daniele “Testadura” Segre piace l’idea che si tratti di un bilancio, idea per lui evocatrice di appendere la videocamera al chiodo: «Per le mie scelte ogni occasione di visibilità è preziosa, non perché m’interessi la notorietà ma semplicemente per continuare a lavorare e esistere. Che mi costa una gran fatica, ma con la soddisfazione della piena libertà». E tuttavia concede di considerarsi abbastanza fortunato, in rapporto alle sue scelte sistematicamente “fuori mercato”. Scelte che ha potuto fare solo in virtù dell’uso di tecnologie leggere e budget ridotti all’osso. Ma talvolta ha potuto godere di sostegni o coperture finanziarie… «Il mio interlocutore naturale dovrebbe essere la tv pubblica. Ma Morire di lavoro, per esempio, la Rai non lo ha voluto». I protagonisti dei lavori di Segre non sono attori, sono persone vere nel loro contesto autentico. «Sempre nel mio cinema, che è incontro con la realtà, c’è l’individuazione di qualcuno che ha il compito di dare linfa al racconto. A guidarmi è sempre la curiosità che mi aiuta a superare gli steccati dell’iniziale diffidenza per raggiungere una condizione di fiducia e naturalezza, per non cadere nella plastificazione televisiva. Stabilendo relazioni intime che ci portano ad appartenerci, con piena consapevolezza e lealtà, io e i miei interlocutori e testimoni. Non ho mai costretto nessuno davanti all’obiettivo>.
Il “documentario” secondo Segre «richiama l’idea di ghetto. Il cinema è una cosa sola. E il mio è cinema della realtà. C’è sempre un regista che guida, c’è sempre una messa in scena. E c’è sempre chi al momento del montaggio compie delle scelte». Eppure un problema di moralità si pone a maggior ragione nel caso di chi porta davanti all’obiettivo storie vere che sono molto spesso anche storie di disagio e sofferenza. Spesso aggravate dall’isolamento e dalla solitudine. Di persone di cui viene testimoniato uno stato di debolezza. Dice Segre: «Svolgo un compito di testimonianza perché mi sento partecipe dell’interesse del Paese. Cercando di offrire a chi è in difficoltà — parliamo in questo caso soprattutto degli operai — la possibilità di esprimersi e raccontarsi, tornando a essere protagonista. Che corrisponde naturalmente a un bisogno anche mio. I miei spunti sono sempre nati d’istinto, a partire da un campanello d’allarme che magari è una notizia sentita al telegiornale. E ogni volta è un viaggio entusiasmante. Anche quando si è trattato di documentare le realtà più crude, ho sempre riversato tutta la tenerezza, la delicatezza e la poesia possibili»
?
Sì, ma un problema morale non è stato anche quello di offrire una tribuna a lotte destinate al fallimento? Una didascalia alla fine di Asuba de su serbatoiu (cioè sul serbatoio: quello, pieno di gas, sul quale salgono restandoci per tutta la durata della lunga protesta gli operai) avverte che tutti i dipendenti sarebbero stati di lì a poco licenziati. «Le mie sono spesso o quasi sempre storie di sconfitte. In questo caso la perdita del lavoro. Protagonisti sono i lavoratori che esprimono il loro essere elemento fondamentale per il benessere e lo sviluppo della nazione. Come tali da rispettare. Mentre invece sono soli. Mi sento in buona compagnia, quella del Presidente della Repubblica, nel difendere con orgoglio e senso di appartenenza la cultura e la dignità del lavoro, e cioè un edificio che si chiama nazione. Il suo futuro».
?Occasioni perse o motivi di rammarico? «Avevo progettato un lavoro su Villa Literno: ero partito, avevo partecipato a un’assemblea ma hanno dato fuoco alla baraccopoli. E poi la bella sceneggiatura scritta con Stefano Rulli sulla vita e la personalità eccezionale di Giuseppe Di Vittorio. Un progetto impegnativo, che andava oltre i limiti stretti della mia piccola azienda. Ma ho capito che un progetto di quel respiro mi era interdetto